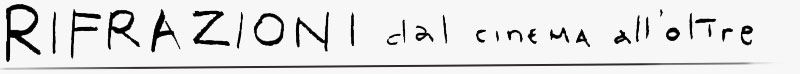
PRESENZA E ABBANDONO: L’ARTE DI ESISTERE AL CINEMA
di MAURIZIO INCHINGOLI
Per farla finita con la vita
Tre modi di abbandonare le scene
Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter Thompson (2008, di Alex Gibney)
Joy Division (2007, di Grant Gee)
Scott Walker: 30 Century Man (2006, di Stephen
Kijak)
BIOGRAFILM FESTIVAL 2008
International Celebration of Lives
Introdotto dalle parole di Giulia D'Agnolo Vallan, in Gonzo: The Life and
Work of Dr. Hunter Thompson ( 2008 ) di Alex Gibney – già autore del
film sullo scandalo finanziario della multinazionale americana Enron titolato
appunto Enron:
the Smartest Guys in the Room (2005) – veniamo catapultati nella vita
a dir poco avventurosa dell'inventore del cosiddetto gonzo journalism, una sorta di
temerario reportage dal di dentro dei fenomeni che il nostro amava esplorare.
Thompson si buttava in-consciamente a capofitto nei fatti di cronaca che
animavano la ribollente cultura statunitense, in particolare quella a cavallo
degli anni Sessanta-Settanta. Il torrenziale film di Gibney sembra rifarsi alla
frase che chiude un pezzo fondamentale dei Jefferson Airplane, quel White Rabbit che chiosava con feed your head, cibate le vostre
menti: in quello specifico caso l'allusione era alle droghe allucinogene che
tempestavano all'epoca, di cui Thompson era cultore e fruitore. Come un viaggio
nella mente lucidamente stravolta del giornalista americano, questo documentario ci
accompagna famelicamente attraverso le innumerevoli vicende storicizzate ed
epocali vissute; come l'avventura con gli Hell's Angels, drammaticamente
descritta nel romanzo omonimo, passando con qualche livido tra le braccia e le
motociclette dei famosi e violenti biker americani, con annessa polemica in
diretta televisiva (in un pericoloso confronto con il leader di questo
movimento). Il nostro passa indenne anche da una fallimentare ma rispettosa
campagna elettorale per diventare sceriffo di Aspen, cittadina del Colorado, e
crede veramente in questa missione impossibile. Cosi come quando viaggia con un
carico di droghe assortite in direzione Las Vegas col suo amico e avvocato
messicano Oscar Zeta Acosta, per sondare per conto del magazine Rolling Stone
la realtà luccicante e perversa dei casinò. Inutile dire che ci vengono in mente, cosi come a
Gibney che ce le mostra, le colorate e psichedeliche immagini di Paura e Delirio a
Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998) di Terry
Gilliam. Non a caso la voce narrante del film è di un appassionato lettore di
Thompson come Johnny Depp, che legge passi del libro con la partecipazione
tipica di un amico e fan sfegatato dello scrittore nativo di Louisville.
Notevole e decisivo è quindi il found-footage di questo film
presentato lo scorso gennaio al Sundance Film Festival, aiutato dalle immagini
in super-8 fornite dalla famiglia, in cui assistiamo anche a divertenti
siparietti del nostro intento a sparare ad oggetti inanimati nel giardino
vicino casa; notoria era infatti la sua passione per le armi, come per l'alcol.
In circa due ore, questo documentario fiume su una delle figure più
carismatiche e profondamente americane, ci introduce in un mondo che sembra
quasi non esistere più. Il lavoro aggressivo di Thompson, come quello ad
esempio di Lester Bangs in ambito più strettamente musicale, è stato col tempo
soppiantato da una forma di reportage che i media americani hanno di molto
edulcorato e per cui hanno coniato il termine embedded. Thompson non amava
questa forma di cronaca spicciola e risoluta, volutamente controllata e
manipolata dai governi di turno, e faceva capire di non gradire gente che si
vendeva per poco. Non a caso negli ultimi anni si era ritirato dalle scene
prima di decidersi a farla finita con un colpo di pistola (sic!), pur di non
assistere al definitivo declino della cultura statunitense, culminata con la
rielezione di George W. Bush. Ci credeva fino in fondo e pensava che le cose
potessero migliorare, invece all'improvviso il buio, e la decisione di chiudere
quasi cioranianamente con la vita, pur di non assistere all'ennesimo scempio
culturale che di li a poco si sarebbe compiuto. Un grande e terminale esempio
di coerenza applicata alla propria esistenza. Una fine con onore, non c'è che
dire.
Alex Gibney rovista e cerca di metter ordine nella vita di Hunter
Thompson attraverso le interviste al suo amico illustratore Ralph Steadman,
alle due ex mogli ed al figlio, con una chirurgica e precisa messinscena da
navigato documentarista. Il montaggio è la principale virtù e la molla che fa
da collante a queste immagini dopate e vitali, che si alternano ad uno score di tutto rispetto con
pezzi di Janis Joplin, Rolling Stones e Jefferson Airplane, tra il meglio che
la cultura americana, e non solo, dell'epoca abbia prodotto. Una alchimia
perfetta e ad alto tasso alcolico che al nostro sarebbe piaciuta non poco. Un
modo divertente e beffardo di celebrare la morte di un personaggio sui generis, che si faceva gioco
dei mezzi di comunicazione, già in un'epoca in cui si cominciavano a teorizzare
pratiche di controllo sulle notizie, dalle quali Thompson si teneva a debita
distanza. Un apologo sull'alcol e le droghe come antidoto per superare lo
squallido e sordido mondo del giornalismo. Un caleidoscopio dal quale si esce
felici e storditi, ma pur sempre soddisfatti. Notevole e finto mocku-film di una
paradossale traslucenza, dalla quale si può vedere tutto in maniera definitiva
e finale.
L'altro film che ha attirato la attenzione in particolare degli
appassionati di musica di derivazione punk new-wave é stato Joy Division, il rock-documentary in concorso di Grant
Gee dedicato alla celebre band (2007). Nell'omonimo lavoro del regista di
Brighton, l'approccio è dapprima volutamente sociologico, con le immagini della
città di Manchester che si sovrappongono alla nascita della band capitanata da
Ian Curtis, singer e personalità complessa che funge da fulcro per la storia.
Come nei film di Ozu, ci immergiamo lentamente nelle immagini analizzando la
città ed il contesto socio-culturale. Ma il modello adottato è anche quello dei
documentari di Frederick Wiseman, antropologo del montaggio e dei fotogrammi,
fermamente distante ed attaccato allo stesso tempo ai suoi personaggi.
In una realtà industriale sull'orlo di una crisi inarrestabile e
quasi senza via d'uscita, prende forma questa band che cambierà le sorti della
musica moderna e della città. Le paranoie e le paure verranno sublimate dai
testi e dall'incedere epilettico e nevrotico di Curtis, che si muoveva inquieto
tra i fans scatenati, e con l'aiuto di Bernard Sumner e Peter Hook,
rispettivamente chitarra e basso dei Joy Division, ripercorriamo la storia di
questa band a dir poco seminale. L'impostazione di Gee è lineare e corretta, il
film alterna immagini di live ed interviste ai comprimari ed alle persone che
avevano rapporti con un musicista geniale e tormentato. La scoperta della malattia, la
relazione conflittuale con la prima moglie e poi la conoscenza della nuova
compagna belga. Il lavoro sull'artwork delle bellissime copertine effettuato da
un'artista visionario come Peter Saville. Le interviste con un mostro sacro
della cultura musicale anglosassone come il dj John Peel. Un biopic nero e
lucidissimo, architettato da un maestro del videoclip come Grant Gee, che è
anche un appassionato di musica (ha girato tra gli altri videoclip per
Radiohead, Blur, Oasis). Chi meglio di lui poteva viaggiare attraverso le crisi
e le glorie di una band cosi fondamentale? In maniera semplice e rispettosa dei
personaggi, veniamo catapultati in una realtà lontana anni luce ormai, come
quella di fine '70, con un inevitabile finale tragico che viene solo evocato.
Ci commuoviamo anche noi davanti alla fatale tragedia che si compirà di lì a poco. Curtis
infatti si suiciderà in casa ingerendo una grossa quantità di barbiturici e con
sul piatto del giradischi la copia di The Idiot di Iggy Pop. Terminale poi la foto che
li immortala per alcuni poster promozionali su un ponte di Manchester, scattata da Anton
Corbijn, anch'egli autore di un docu-film sulla band titolato Closer (2007).
Un omaggio dovuto e prezioso di cui ogni appassionato di musica
non dovrebbe fare a meno. Un viaggio nella mente di un talento che era
consapevole della sua posizione scomoda, e che faceva per questo parlare solo i
suoi compagni di viaggio. Un’unione perfetta di suono applicato alle immagini
livide e nere, una crasi drammatica e definitiva. Dopo solo un lungo silenzio…
e di corsa ad ascoltare il testamento musicale lasciato dal nostro. Unknown Pleasures dalla terra
d'Albione.
Il nostro personale viaggio termina con una sorpresa che invero
non ci aspettavamo di incontrare. Fa capolino nel cartellone del festival Scott Walker: 30
Century Man (2006) del regista americano Stephen Kijak.
Come un diamante incastonato in un anello luccicante, la
sorprendente pellicola dedicata al musicista nativo dell'Ohio, ormai
trapiantato in Gran Bretagna, immortala la vita di Walker partendo dai fasti
dei primi anni sessanta con i Walker Brothers, boy-band ante litteram per
antonomasia, e si avvicina poi alla realizzazione di dischi solisti e monstre come Climate of Hunter (1984), Tilt (1995) ed il recente The Drift (2006).
Scott Walker si concede finalmente alla videocamera del filmaker
americano, che ripercorre le varie fasi della sua incredibile carriera.
Ricordando il quasi anacronistico (per la cultura statunitense dell'epoca)
amore per i film d'autore europei, in particolare per quelli del maestro
svedese Ingmar Bergman, e per gli autori della Nouvelle Vague, ma anche la
rocambolesca scoperta delle canzoni di Jacques Brel, a cui dedicherà anche un
suo lavoro, in cui reinterpreta le canzoni dell'autore fiammingo.
Un'ora e mezza di purezza dark e talento spaventoso tradotto in immagini
mozzafiato, che testimoniano anche e soprattutto la fase di immersione totale
nell'anonimato del misterioso musicista, specie dagli anni '80 in poi, per
centellinare sempre di più le apparizioni pubbliche ed i propri lavori, che si
fanno via via sempre più introspettivi e criptici. In una sorta di voluta
decostruzione pop filtrata attraverso le istanze più avanguardistiche che il
nostro potesse concepire. Con produzioni al limite del maniacale e
dell'assurdo. Impressionanti a questo proposito le immagini girate negli
studios londinesi per la registrazione dell'ultimo, stratosferico lavoro uscito
per 4AD. Sembrano intercettate attraverso il buco della serratura, tanto discreto è il girato di Kijak.
Il film è prodotto da David Bowie, che intervistato per l'occasione non
nasconde una certa malcelata invidia per lo sconfinato talento di Mr. Walker.
Facendo il paio con le dichiarazioni di Brian Eno, altro grande
musicista-produttore che però forse non riuscirà mai a lavorare con talenti del
genere, pur avendo fatto grandi cose con gente come Talking Heads e Roxi Music.
Enorme, irraggiungibile meteora che vive in disparte e lontano ere
geologiche dalla musica moderna attuale. Addirittura era in grado di fare
impazzire letteralmente di gioia grandi jazzisti dell'avanguardia britannica
come Evan Parker. Cosa c'è da aggiungere ancora?
Dopo questa catacombale visione tutto il resto sembra superfluo, mancano le
parole. Prepariamoci ad una lunga fase di gioiosa riflessione, costernati
davanti a cotanto innat(o)urale genio della musica contemporanea, che è
riuscito ad unire per sempre in maniera inscindibile l'avanguardia con gli
stilemi più s-comodi della musica pop-ular. Un poeta delle note, un silenzioso
e sornione kamikaze sempre alla ricerca di un muro invisibile da abbattere. Un
mastodonte timido e umile.
Il lavoro di Kijak è per forza di cose quasi schiacciato dalla
grandezza di Walker, sembra quasi che ci sia del suo solo nei bellissimi ed
inquietanti titoli di testa, dove una femminile e catramosa voce narrante ci
introduce nei meandri più bui e nascosti della vita del protagonista. Un modo efficace di
approcciarsi ad una materia scottante come quella creata e plasmata da Walker.
Un piccolo capolavoro, una gemma nascosta.
Uscendo da queste sorprendenti proiezioni la prima riflessione che
ci viene in mente è che – come una finestra sul mondo, come una luce in fondo al tunnel,
attraversando le fasi più buie dei protagonisti di queste preziose pellicole – s’intravede un
barlume di inaspettata vitalità per il cinema contemporaneo di questa specifica
fase storica. L'individuo è il soggetto dei migliori film che escono negli ultimi
tempi al cinema. Unite ad una forma di documentario sempre più affascinante ed
accattivante. L'umano (troppo umano) prima di tutto, in-sostenibile oggetto perfetto da sondare e
cristallizzare. Come in una fotografia od ancora più indietro nel tempo in un
dagherrotipo. Forse il cinema sta tornando alle proprie origini. O forse è come un'anziano che
torna bambino e ricorda le proprie origini e la passata gioventù. Forse è la fine del cinema
cosi come comunemente inteso fino ad ora, o la sua rinascita e trasfigurazione
in una forma meno mediata da sceneggiature appositamente inventate. O forse la mancanza
del sogno, e solo la dura realtà. Chissà, intanto godiamoci le suggestioni di
questi fotogrammi di accecante bellezza visiva e soprattutto sonora. Il
connubio (o delitto) perfetto...
Questa è la nostra storia...
The
Last Western (2008,
di Chris Deaux)
This
American Gothic (2005,
di Sasha Waters Freyer)
BIOGRAFILM OFF 2008
(Bologna, Vicolo Bolognetti)
La
fretta di farsi storia. È la prima riflessione che viene in mente assistendo alla proiezione di
questi due piccoli documentari che scandagliano un'America sconosciuta ma
vogliosa di essere parte delle evoluzioni della società odierna, che
necessariamente si basano sul concetto di riconoscimento storico per esistere ed essere considerate parte
integrante della stessa. Ma sembra più una preoccupazione del regista che dei
personaggi protagonisti delle pellicole, che anzi, non hanno nessuna intenzione
di lasciare questa terra, pur ambendo a far parte di quella storia.
Con The
Last Western (2008) ci addentriamo in una realtà che sa di naftalina e di museo impolverato.
Buzz, il perno attorno al quale si snoda il film di Chris Deaux, è un simpatico
residuato figlio di una comunità hippie che si è stabilita alcuni decenni fa nella cittadina di
Pioneertown fondata da Gene Autry, attore della ultima ondata di western
seriali, in pieno deserto del Mojave; un tempo location ideale per set
cinematografici e serial televisivi come The Cisco Kid, non distante da Hollywood, e poi
successivamente trasformatasi in luogo per dropouts ed Hell's Angels, che
soprav-vivevano solo grazie ai sussidi, ed in alcuni casi allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Una comunità di bianchi e w.a.s.p. rinchiusa in se stessa,
con il culto della nazione e della bandiera a stelle e strisce. Tutta presa ad
inseguire i ricordi ormai perduti di un passato mitizzato, che rimane impresso
solo grazie a cimeli e vecchi orpelli che arredano le loro case-magazzino.
La
galleria di personaggi che anima questo documentario è quanto di più
anacronistico ci possa essere sulla faccia della terra, lontana anni luce dai
quartieri multirazziali che animano città-metropoli come New York o Chicago;
qui il tempo sembra essersi fermato, pare di essere catapultati negli anni '50,
quando una nazione rurale ma già comunque proiettata nel futuro dominio
mondiale, formava persone per bene, ma anche freaks pronti a sovvertire le regole di convivenza civile
attraverso un uso spropositato di alcol e droghe, per poi rifugiarsi (scacciata
quasi) nel ventre molle di questa enorme landa che abbonda in spazi ed in
recinti fisici e mentali, dove però tutti hanno la possibilità di crearsi il
proprio mondo e la personale comunità insieme ai propri simili. Cristallizzare
la giovinezza e gli ideali, mettere da parte le sindromi e la solitudine
alimentando passioni come la musica ed il cinema dei vecchi tempi andati.
Abitando ai margini, in posti che sono deserto e sabbia, lontano dalla città
corrotta e perduta. Ogni personaggio racconta la sua storia ed il suo declino,
compiaciuto ma anche disilluso, ed in fondo stanco. L'età media d'altronde è
altissima, ed i processi della globalizzazione, questa sconosciuta, sembrano
aver intaccato solo in minima parte le loro convinzioni. Come un vecchio vinile
gracchiante, con la puntina che ne traccia il solco, ad inseguire come in un
eterno loop quella vitalità ormai persa. Buzz infatti morirà circa una
settimana dopo aver finito di girare il documentario. E con lui se ne andrà un
pezzettino di quella eterogenea e variopinta società che si rinchiude in se
stessa in una paradossale ed impossibile eternità. Se ne andrà con lui anche la
sua amata musica rithm'n'blues, e rimarranno soltanto i ricordi della anziana madre.
Insieme a quelli degli abitanti superstiti di Pioneertown. Come in una vecchia
cartolina ingiallita dallo scorrere inesorabile del tempo, questa pellicola
immortala definitivamente un piccolo tassello di storia che andava
assolutamente fermato e lasciato ai posteri.
“The
Last Western is the story of the old west town Hollywood built and then
forgot":
questa è la triste frase che campeggia nel sito internet del film, quasi a
ribadire una fatale e logica conseguenza dell'industria del cinema, che usa
posti e persone come fossero manichini. Peccato però che alcuni individui
rimangono stregati dai fumi della settima arte, e stoici, fanno letteralmente
la polvere. La grande dis-illusione che manca a degli onesti abitanti di questa terra.
Come
quelli della cittadina di Eldon nello Iowa, 998 anime quasi tutte ossessionate
dal famoso dipinto di Grant Wood, This American Gothic, che viene preso a modello di una
vita frugale e semplice, a corredo dei sani principi e valori della società americana. Ammetto
di non amare troppo il recupero delle radici, specie se attuato da anziani che
si rifiutano di confrontarsi con il mondo contemporaneo, ma forse non posso
capire certi ideali. Meglio ri-attualizzare invece alcuni concetti alla luce
dei cambiamenti che subiamo ogni giorno, piuttosto che salire su un immaginario
piedistallo e ricordare come si usava una volta la vanga per dissodare il
terreno, ed altre amenità simili. Ci sono i trattori moderni per questo! Ma
tant'è, la regista si mantiene a debita distanza da tale antica usanza, e quasi
ad esorcizzare il tutto piazza, tra un frame e l'altro, pezzi di rock moderno
di gruppi come Mogwai, Built to Spill e The Beta Band. Il mondo va avanti, la
cultura si è impossessata di questa comunque efficace icona e l'ha trasfigurata
in varie forme e modi espressivi. Non a caso viene citata la scena dal film The
Rocky Horror Picture Show (1975) diretto da Jim Sharman, che parodizza in maniera ineccepibile
la mise'n'scene di quel quadro. Cosi come fanno copertine di magazines e dischi usciti negli anni
a venire. Ma lasciamo una speranza di vita a questa comunità di poche anime,
che forse ha solo fiutato un discreto affare per il turismo: come biasimarli.
Confesso che ad un certo punto anche io volevo vestirmi come il patriarca del
dipinto, accostarmi ad una donzella, e tenere in mano un forcone a ricordo
delle mie origini contadine, sic! Ho fatto tanto per ripudiarle, ma forse sto
solo delirando troppo! È che le sagre di paese non le amo particolarmente, ma
amo tantissimo il cibo e la parte più materiale della cosa. Riempire lo
stomaco, bere, trangugiare divertiti la nostra storia, facendoci una grossa
risata. Senza segno della croce però, e poi ritornare seriamente al proprio
lavoro quotidiano. Mantenere le distanze e come dice John Giorno in una sua splendida
poesia: just say no to family values!
Sasha
Waters Freyer si affida a storici di fama e giornalisti professionisti per
fissare il momento da cui nasce tutto, ed in effetti sembra non credere poi molto a certe
teorie. Il film è di fatto un buon reportage su una stramba ed obesa comunità del Midwest, intenta a
reificare e lucrare, a fin di bene s'intende, su un'opera d'arte e sulle
conseguenze che questa ha lasciato nella cultura statunitense.
La
fretta di farsi storia
dicevamo all'inizio. Per dominare il mondo bisogna aver vissuto, costruito,
distrutto, invaso ed inculcato la propria cultura allo straniero di turno. La
caduta dell'impero americano verrebbe quasi da dire; invece amiamo pensare che gli
Stati Uniti sono una fucina di talenti. In fondo è ancora un paese giovane ed
in grado di cambiare le sorti del mondo: nel bene o nel male, questo sta ad
ognuno di noi deciderlo.
I miei
nonni usavano la zappa per lavorare in campagna, mangiavano cose buone e
conducevano una vita sana, io però non ho nessuna intenzione di farlo alla
stessa maniera. Sono una persona moderna, e mi piace rispondere cosi (passatemi la
digressione) alla domanda che faceva la bimba al papà nell'illuminante e spaventoso film Dall'oggi al domani (Von heute auf morgen, 1997) di Jean Marie Straub e
Daniele Huillet. L'evoluzione nell'uomo è inevitabile, che la si voglia o meno,
e se si crede di essere superiori bisogna superare e combattere i propri demoni, sennò si
fa la fine speculare di quelle persone che tanto facilmente la società
americana denigra e ghettizza, rinchiudendola per esempio a Guantanamo. E
lasciamo in pace Grant Wood ed i soggetti del suo dipinto, meritano rispetto e
riposo, hanno lavorato tutto il giorno nei campi...
|
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -