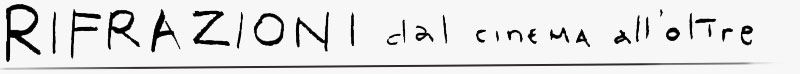
L’ODIO SILENZIOSO DI UN PROFETA
Su Il profeta (2009, di Jacques Audiard)
di MARTINA BONICHI
«Questa è la storia di un uomo che
cade da un palazzo di cinquanta piani. Mano a mano che cadendo passa da un
piano all’altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: “Fino a qui tutto bene.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.” Il problema non è la caduta, ma
l’atterraggio».
Dal nero dello schermo echeggiano
le parole di Hubert e prende vita, al centro del quadro, l’immagine del mondo
sul quale si schianta una bottiglia incendiata.
Immagini di repertorio ritraggono
l’odio tra le bande nelle banlieue parigine e raccontano un giorno e una notte
vissuta da tre ragazzi, un ebreo, un maghrebino ed un nero che si fanno scudo
l’un l’altro contro un regime che li vuole allo sbando.
Sono passati circa quindici anni
dalla realizzazione di L’Haine (1995) di Matthieu Kassovitz. L’odio, nel film del
giovane regista francese, emerge dalle parole, prorompe nelle immagini, si
legge negli sguardi spietati e spersi dei tre protagonisti, nei ghetti delle
periferie parigine, che si scontrano con la polizia dopo che un loro amico
rimane vittima di un conflitto a fuoco. Ora, alle 62a edizione del Festival di Cannes, con Un prophète, Jacques Audiard mette in scena
l’odio contenuto e misurato di un giovane uomo che nascosto nella sua cella,
impara le leggi del potere, intesse relazioni silenziose ed una volta imparato
a convivere con i propri fantasmi, uccide il padrone, ormai indebolito e solo,
assumendone il ruolo. Malik, occhi ed orecchie dei potenti, è un giovane
francese di origini maghrebine che sembra non appartenere a nessuna razza,
condividere nessun valore, aver fede in nessun credo. Ed è questa la sua arma,
la legge alla quale si affida, imparando da ognuno: brutale come i corsi e
riservato e discreto come i “fratelli” arabi.
Né cattolico, né musulmano, né
francese e né arabo, ha in sé una curiosità tale da permettergli di diventare
chiunque. Con solo cinquanta franchi nascosti nelle scarpe entra in galera
tenendosi stretta la testa fra le mani. Le urla dei galeotti ed un violento
sbattere delle celle dietro di sé lo trova smarrito, sperso, isolato in un
mondo, lo stesso di fuori solo con dei recinti più stretti, in cui vede sfilare di fronte a sé le bande dei
potenti.
Le porte si aprono, i cancelli
sbattono e le chiavi nelle serrature raccontano di vite messe in cattività.
Nessuna immagine viene ancora mostrata e già i rumori di una galera introducono
la realtà di un carcere francese mentre il nero dello schermo si lascia
attraversare dai titoli di testa. Una forma circolare richiama l’iride del film
muto. È la sua “mano negra”, quel vezzo di cui Audiard si serve già dal primo
film, girato in super8, in cui mette in risalto un oggetto, una forma,
lasciando in ombra il resto del quadro. Compare una mano, quella di Malik, poi
le manette e la realtà di una storia carceraria prende vita. Occhi attoniti,
impauriti, braccati seguono le voci fin dentro le celle che si richiudono alle
sue spalle. Dopo un particolare ed un altro, l’immagine si mostra nella sua
interezza ed un sipario sembra aprirsi sulla storia di un giovane uomo che
dovrà scontare sei anni fra i grandi, quelli che fanno paura anche agli altri
detenuti, quelli che corrompono i secondini, che mantengono i rapporti anche
fuori e che detengono il prestigioso e temuto ruolo di cattivo. Malik, quasi una figura pirandelliana, da
inutile nessuno diventa profeta: chi vede lontano, chi ha la lungimiranza per
capire che certe azioni comportano determinate reazioni. Scelto fra tanti
nessuno, la banda più spietata, quella dei corsi, lo prepara al suo rito di
iniziazione: uccidere un arabo. Rejeb, primo capitolo che racconta come l’uomo
che Malik, deve avvicinare ed uccidere sarà una figura costante nei suoi
silenzi, nei suoi sogni. Un fantasma che sembra sfidare, quando gli domanda,
nel silenzio di una cella, sdraiato sul suo letto: «Sei qui?».
Reyeb è con lui, sempre, e non
solo diventa la sua ombra con la quale parlare, la sua arma con la quale ha
imparato ad uccidere, si fa anche la sua coscienza. Da semianalfabeta, Malik
comincia a studiare, impara a leggere e sempre più, dentro di sé, acquisisce la
consapevolezza che la sua legge è la sopravvivenza, il suo credo è emergere.
Lontano dagli schemi dei film carcerari, da Un condannato a morte è fuggito,
Papillon o Fuga
di mezzanotte, Un
prophète segue
una realtà sociale attualissima della Francia di oggi e non solo, in cui un
uomo ha bisogno di evolversi, tentando la scalata al successo per sopravvivere,
solo con la furbizia e la scaltrezza, uniche armi che possiede. “Reyeb”,
“Ryad”, “Jordi” sono i capitoli che scandiscono i tempi e le tele che intesse
il giovane profeta finché il suo tempo ed i suoi giorni lo vedono prigioniero.
Allo scadere del sesto anno, varcati i cancelli della prigione si avvia accanto
al suo futuro, fatto di semplicità ed innocenza con una compagna ed un bambino,
mentre dietro di sé sfila la nuova banda dei potenti di cui è ora lui stesso il
padrone. Non c’è terrore, violenza o disperazione come nelle figure di
Kassovitz, ma una calma misurata, un’attesa che si fa pressante ma
coscienziosa, ed una precisione con la quale il protagonista è presente a se
stesso, e che solo nei momenti in cui deve uccidere, per affermarsi, sembra
perdere. Una lametta nascosta nella bocca ed una pistola, i cui colpi dentro
una macchina lo stordiscono facendolo sentire leggero ed ormai in cima alla
vetta, al di sopra di ognuno, sono
gli unici momenti in cui si
afferma nella brutalità di un malavitoso, una brutalità che non gli appartiene,
un chiassoso modo di agire lontano dalla sua natura che lo vuole silenzioso,
mentre nell’ombra afferma se stesso e raggiunge l’apice di un lungo
apprendistato durato sei anni.
Il profeta, o “little big man”, come lo stesso regista
racconta, è il nuovo prototipo di uomo. Lontano dal clichè del galeotto
violento e spietato, Un prophète di Audiard è l’antieroe per
eccellenza, quello che non può dominare sugli altri con la fisicità dei suoi
muscoli ma con una scaltrezza innata, protesa al fine di una vendetta
silenziosa che lo porta, da ultima pedina di un sistema gerarchico, alla sua
vetta. Da schiavo a padrone, Malik diventa una parabola della modernità, un
racconto morale nella sua amoralità, descrivendo con una distanza tale da
oggettivare il bene ed il male come realtà uguali, entrambe descritte come
mezzi per raggiungere la libertà di un giovane uomo – un simbolo, che non
si vuole elevare ad eroe ma solo descriverne la paradossale ascesa che non si
sarebbe mai avverata se non in prigione, sistema che ironicamente genera e
rinforza quella stessa criminalità che dovrebbe sconfiggere.
|
 |
- i n f o @ r i f r a z i o n i . n e t -