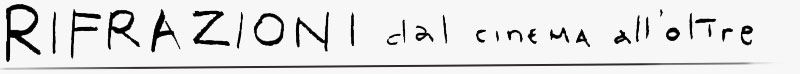SOSPENDERE IL RESPIRO SULLA SOGLIA
su Soffio (Soom, 2007, di
Kim Ki-duk)
di MARGHERITA PALAZZO
Schwärzer
im Schwarz, bin ich nackter.
Abtrünnig
erst bin ich treu.
Ich bin du, wenn ich ich bin.
più nero nel nero, io sono più
nudo.
Apostata solo, io sono fedele.
Io sono tu,
quando io sono io.
Paul
Celan
La protagonista di Soom, l’Ospite, è un dolcissimo e perverso morto vivente,
più del condannato al quale lei porta in dono carta da parati, illusione
condivisa, appuntamento tra fantasmi. L’effettiva incidenza della sua presenza
nel parlatorio è irrilevante rispetto al bisogno disperato che si tenta di
soddisfare: più Jang Jin, il Prigioniero, si avvicina alla Visitatrice Hong
Ju-Yeon, con le movenze scomposte e sospettose da animale in gabbia che
contraddistinguono tutti gli eroi maschili esausti, diffidenti, di Kim Ki-duk,
più Yeon si allontana, persa in un sospetto e quieto delirio che ci dona il
presentimento ancora di altre intenzioni, altre
nevrosi rispetto a quelle che vengono messe in scena e riprese. Vi è una
proporzionalità inversa tra il risveglio del prigioniero richiamato alla vita e
l’intensità dell’interesse della turista
di prigioni che lo mette in moto: così come non prende forma attraverso il
reciproco contatto, ma era già formata, tra l’inabilità alla morte
di lui (i tentativi di suicidio, sempre fallimentari) e l’inabilità alla
vita di lei (irresolubile). Costei si esercita ad infrangere le gabbie degli
altri, che riesce a vedere, e perfino a scolpire (lo
squarcio nella statua che sta modellando è l’unica apertura da cui una statua
può urlare) ma deve operare secondo l’unico modello che le garantisca di non
riconoscere la morte vivente del suo
matrimonio, di non infrangerlo drasticamente: soffocare il prigioniero, sia
pure con un bacio, è per lei,
incubatrice di desiderio e custode di maritali camicie bianche pronte al
suicidio, una catarsi asettica, che le permette di rivivere in una camera
sterile, nell’ambiente protetto di un laboratorio, l’esperienza di perdere fiato. Non essendo risolvibili
in alcun modo i conflitti nella vita di Yeon, non è nella sua vita che si può spingere l’azione, quanto nella morte –
per quanto emozionante, per quanto sensuale – del Condannato a un’altra morte meno erotica. Di quella parte di sé che è inconciliabile
con la vita, l’essere umano (poco importa se donna, poco importa se moglie)
Yeon, in gabbia quanto l’altro, cerca di liberarsi in territorio desertico,
dove non c’è pericolo di infezioni, al cospetto di
qualcuno che porterà con sé il segreto dell’umana inettitudine: niente di ciò
che succede nel parlatorio esce fuori, e in questo senso il tecnico del monitor
non è affatto il regista, non ha controllo su alcunché: è un comune impiegato,
solo destinato a far sì che l’esperimento proceda secondo correttezza scientifica. Se c’è un voyeur, un marionettista, la Visitatrice è il voyeur, lo sperimentatore, il contagio angelico; non il secondino,
l’osservatore per eccellenza che di fatto cerca soltanto di evitare un vizio procedurale,
interrompendo gli incontri quando non si sono ancora create le condizioni
perché in parlatorio si manifesti il tentativo vampirico di soffiare via la
propria vita non voluta e di berne dal soffio dell’altro. Si tratta di
nient’altro che di un’altra cella (spoglia dalla carta delle stagioni e dalle
canzoni, scenografie di una vita che non si vuole più, o che si è già
distrutta). Più precisamente, la donna inocula il virus della vita nel
condannato a morte, allo scopo di risentirlo attraverso il suo corpo: sentire
la vita attraverso la morte, come le capitò per caso quando era bambina,
rischiando per pochi minuti di annegare, come l’amante dei melodrammi che
applica la sua bocca su quella del morente nel tentativo di catturare una
scintilla, qualunque cosa, e farla
durare, come un amante shakespeariano che tenta di sequestrare l’ultima goccia
di veleno dalle labbra perdute, che è ancora fluido vivo e personale, benché
mortale. Non si tratta di condurre al Condannato le stagioni per distrarlo
dello scorrere tremendo del tempo che manca all’esecuzione, o di rappresentare
un percorso più rapidamente di quanto non sia possibile nella realtà di un
rapporto: è la donna che ha bisogno di tempo, di dare a lui il tempo di assimilare una sorta di resurrezione, e di
crederci. Anche questa è una pratica sperimentale,
ricreata in vitro. Ciò che si cerca è la prova empirica di qualcosa che si
ripete, che forse si può ripetere: respirare ancora. La forza attrattiva che
guida la donna, la sua attenzione per l’estraneo nella cella, non è solo rivelatrice, ma in attesa di una rivelazione: non richiama definitamente,
andando a ritroso, nessun altro personaggio femminile creato da Kim Ki-duk; non
coincide né con la stupefatta passività di un’altra moglie, quella di Ferro3 (Bin-jip, 2004), né col vaneggiamento di Mee-Young, fantasma in pena
alla ricerca dell’amante morto attraverso i corpi dei vivi in Haeanseon (t.l. La guardia costiera, 2002); non corrisponde alla pietà infantile e
smarrita delle samaritane (in Samaria, 2004), né al sorriso misterioso
e astratto della bambina de L’Arco (Hwal, 2005); né alla disperazione
gentile della protagonista di Paran daemun (Birdcage
Inn, t.l. La porta blu, 1998) o a
quella misericordiosa della donna che in Crocodile (Ag-o, 1996) accarezza dolcemente le
ferite del suo stupratore-anfibio, e neppure alla goffaggine, alle lacrime e
alla tenerezza della studentessa di Bad
Guy (Nabbeun namja, 2001).
Ancora: i suoi rari scatti, i suoi impeti, non hanno nulla in comune con la
selvatichezza della sirena de L’isola (Seom, 2000), parabola fisica in cui
letteralmente si deve scovare e trarre a sé il corpo dell’altro, e il proprio
corpo verso quello dell’altro, con ami da pesca: sono piuttosto figli
dell’inquietudine senza rimedio della protagonista di Time (Shi gan, 2006), figli di quei travestimenti dichiaratamente
inefficaci proprio quando diventano più radicali, tentativi di trovare una collocazione presso se stessi, e nel mondo: di darsi un volto con
la forza, di rigettarlo poi con la stessa forza, senza che si risolva nemmeno
per un istante il mistero del tempo e della consunzione dell’amore e la sua
crudeltà. Il cinema di Kim Ki-duk, lungi dal rappresentare un addomesticamento
della poetica di una volta, o l’abbracciare una metafisica consolatoria, solo
apparentemente si libera ora dal peso (che morde) della materia. In una scena di Address Unknown (Suchwiin bulmyeong, 2001), non a
torto considerato uno dei momenti più duri e feroci del suo percorso, Eun-ok
– innamorata e amante di un cucciolo di cane, cieca per gioco, per caso e
poi per naturale inscrizione nel codice della sofferenza che trova nella
mutilazione una forma di riscatto – in un primo tempo si lascia applicare
sul viso la sagoma di un occhio, ritagliata da una rivista, un gesto che sta a
dimostrarle che è possibile cambiare volto, da parte di quello che sembra il
corpo amichevole e sano del suo salvatore; in Bad Guy, per romantica e
crudele ironia, Sun-Hwa l’Ingenua si
traveste con parrucche, abiti, rossetti, nello sforzo ancora di diventare se
stessa, ovvero quell’altra della
quale ha percepito la presenza versando lacrime di nostalgia contro lo specchio
da cui viene spiata da un amoroso killer; in Time, i ritagli di giornale, i frammenti di volti estranei, e in
particolare la maschera dai tratti immobili e ridenti, già non sono più
maschere: per Seh-hee sono insegne di dolore e di desiderio portate davanti al
viso come un’arma, segni di battaglia già
avvenuta che servono a terrorizzare, ipnotizzare il nemico (colui che ama)
accusandolo eternamente di essere stato la causa indiretta del proprio cambiar faccia; per la donna di Soom, infine, non è più nemmeno necessario accusare un colpo, subire o scegliere
una ferita e nasconderla dietro a un artificio, per dichiararsi mutilata:
l’amputazione è a priori. L’incapacità di vivere davvero ha già contraffatto
quotidianamente mille volte il suo viso, rispetto a un
passato non filmato che non conosciamo; lo ha già scolpito, come lei stessa
scolpisce i suoi patetici, graziosi angeli dalle ali corte: la ricerca di un
volto autentico qui è fallita già in partenza, la schiavitù congenita, come un
morbo genetico, che progredisce autonomamente senza ricevere neppure la pietà
del dramma. Il viso, mutilato oppure no: la questione è vacua, come per la Madame Psychosis di Infinite Jest che copre con il velo una
«Deformità Repellente e Improbabile».
Da questo punto di vista, il cinema di Kim Ki-duk non accetta quella qualità
eterea che gli si attribuisce rispetto alle sue opere precedenti: gioca anzi
con una materia se possibile ancora più disperante, perché si fa invisibile e
incatalogabile, una massa occulta e incombente, che fa pensare al carico di
nebbia e di paure che si portano dentro i personaggi dei film di Kiyoshi
Kurosawa, quel senso di morte e di un’incisione costante che lo scorrere dei
giorni e degli anni pratica su cose, ambienti, persone, tentando di farne
oggetti decorativi, afoni, senza nome, malgrado la
loro ribellione muta. In questo senso il sangue viene sparso ormai soltanto come disegno, sulla parete e sul volto del compagno di
cella di Jang Jin, come ultimo quadro da citare, perché non si può
rappresentare la solitudine ormai nemmeno più con i corpi macilenti, offesi, di
Schiele: soltanto con il sangue si può dipingere, e soltanto con il tratto
incerto di un bambino. Ma questo sangue non viene più
filmato: forse si tratta dell’esasperazione di chi non solo ha perso la facoltà
di esprimersi con la parola, ma non è capace neppure di violenza, soltanto di
uccidere con un bacio: la prigione (quella più vasta del carcere) è subdola e
prossima al territorio asfittico della morte, alla soglia – la zona grigia, silenziosa e urlante, in cui bene e
male non sono semplicemente contrari: la figura che tiene insieme
contraddittori concettualmente inconciliabili: il bene e il male, la vita e la
morte, il pensiero e l’assenza di pensiero, il silenzio e le parole –
laddove non conta più nemmeno il sangue, ma soltanto il respiro. Il respiro di Soom non è asciugato dalle lacrime e
dagli umori, raffreddato in un quadro che lo spinge verso un ideale liberato
dalla carne, ma soltanto sospeso in uno spazio di infinito
distacco, in cui si cerca ancora la breve guarigione, il sollievo grottesco di
poter dire «Sono unicamente un corpo. Soltanto un corpo, come un cane». Nel momento decisivo, bisogna che Yeon riconosca la ragione dei tentativi di
suicidio di quell’uomo, e disconosca contemporaneamente il proprio tentativo di
salvarlo: tornati alla realtà brutale, è lei che soffocava, oppressa da una
parte di sé talmente desiderante da poterla aggredire soltanto attraverso un
altro corpo, che smetta per un attimo di respirare insieme al suo. Proprio nel momento più drammatico e sensuale, il monitor rifugge
dall’inquadrare la carneficina erotica e si affaccia all’esterno, a seguire il
quadretto invernale del marito, buon padre, in fondo, che gioca a palle di neve
con la figlia; se nella cella si svelano (e si feriscono a vicenda) le verità
di due individui profondamente soli, una terza solitudine, la famiglia della
donna, marito e figlia, galleggia all’esterno senza possibilità di ricomporsi,
né di comprendere. Ci sembra quasi che solo per inanità, o per taciuta
vigliaccheria, la moglie mansueta non aggredisca invece il marito o la figlia.
Il Condannato, la sua famiglia, l’ha risolta da tempo, come ci racconta un
notiziario impersonale, l’ha smantellata,
azzerando per sempre quel respiro e il proprio; la donna invece vuole ricreare
in vitro il soffocamento senza però viverne l’orrore: un soffio mortale, ma
solo per finta: ecco perché deve farlo provare a lui, specchio, schermo; deve
essere nuovamente ucciso, colui che è stato
resuscitato attraverso le quotidiane Eucaristie senza cerimonia, basate
sull’ingestione di capelli e fotografie, che succedono alle visite. Il Condannato riporta in pegno dal suo primo incontro
con la Sconosciuta un singolo capello, residuo di magia nera che deve essere
nascosto per ricetta stabilita all'interno della bocca, ripercorrendo i passi delle
leggende e tradizioni carcerarie, medicali o avventurose: laddove si nascondono
lime nelle torte, pillole in fondo al palato, coltelli nel materasso, lettere
nella camicia, vicino al cuore, Jang Jin nasconde la promessa di un nuovo
incontro nel suo corpo, centro di pulsazioni incapace di esprimere altro che
questa attesa commovente, non dichiarata: i segni dei suoi innumerevoli suicidi
kafkiani sono racchiusi solo ancora in una ferita sulla gola (come quella del
Bad Guy), là da cui devono nascere la voce, ciò che si tenta di strappare alla
morte, sempre perdendo la partita, e il più autentico dei respiri. Anche
una foto sarà ingerita, per essere sottratta alla curiosità morbosa dei
compagni di cella e in particolare alla gelosia di uno di loro, il ragazzo che
approfitta dei sogni inquieti dell’altro per elemosinare un contatto fisico, colui che diventerebbe volentieri la Pietà d’occasione nel
braccio della morte; ma naturalmente anche per essere assorbita, come in ogni
pratica magica, per assimilare e conservare colei che è arrivata quando la
speranza era alla fine. In Soom non
c’è neppure l’istante di indecisione di Crocodile (dove il protagonista nel
finale tentenna: salvarsi, o restare per sempre nell’universo anfibio che ha
cercato di costruire) ma solo la determinazione febbrile a respirare che si
scontra con l’assoluta impossibilità di farlo; l’ultimo tentativo è quello di
affidarsi a un esperimento folle, che tenta di ribaltare le costanti del tempo
e dello spazio, fantascienza
dell’incontro con l’altro. L’ultima visita è spoglia, quasi un esame: la
Visitatrice non indossa abiti, non reca oggetti, come se non ci fosse più
nemmeno la necessità (o la possibilità) di apparecchiare un incantesimo: Jang
Jin, il Condannato, è un contenitore di attese
disilluse, un confessionale, uno schermo vuoto su cui proiettare le immagini
stereotipate e dolenti delle stagioni e del tempo per sempre mancante; uno
schermo, lui, ben più del monitor che il secondino-regista controllerebbe.
Costui interrompe tutti gli incontri, salvo quest’ultimo: forse ha lasciato che
maturasse in loro il segno della frustrazione, quello sottile e corrosivo che
si sprigiona come un gas letale e avvincente dalla semplice scossa
dell’interruzione; per cui tutti i passi sarebbero
rimasti soltanto una finzione, se non avessero mai raggiunto l’estremo della
verità. Gli incontri, le feste di stagione, che riproducono i colori e i suoni
senza poter pretendere di ricostruire anche i profumi, sono giochi di ruolo in
cui si traffica con la realtà e con la verità, che non sono cancellabili, anche
se si possono manipolare: la visitatrice già morente, e il condannato sottratto
a forza dalla tomba della sua punizione agiscono in un ambiente concepito in
modo tale che ogni azione resti senza conseguenze; ma se per lui si tratta di
un autentico respiro, di cui si appropria disperatamente come un bonus dopo quello già esalato, tutti i gesti della donna sono
ripetizioni, innescati da ciò che nella vita "di fuori" non si
risolve, la stessa materia spessa e inconoscibile che nella sua vita familiare
porta immancabilmente a teatrini patetici e frustrati, mentre nella cella
conduce all’incontro fremente tra i corpi, che è ben più reale di ciò che la
vita stessa può offrire. Ma la condizione necessaria e
sufficiente è che tutto ciò si riveli nello spazio della prigione: in cella si
può dichiarare che fuori tutto è cella, fuori non si può pronunciare un simile
verbo, non si deve affermare, perché altrimenti non si può vivere. Vediamo il volto noto del regista a monitor
spento, su una scena che certamente prosegue al di là del suo guardare: non suggerisce, questo,
piuttosto un senso di scoramento, un’impotenza, invece che un delirio di
onnipotenza creativa? Kim Ki-duk si prende tutt’al più il ruolo di custode del
tempo, ma è un ruolo che non ha nulla di solenne: non è tanto lo spietato
dittatore che governa i destini dei suoi personaggi, né un’autorevole divinità,
ma il piccolo burocrate che immaginiamo magari un po’
volgare e non troppo colto, attirato dalla figura di una donna, che batte le
mani come un grosso bambinone sadico e infantile alle canzoni gioiose di Yeon e
lascia che marito di lei possa vedere,
non come un complice, o giustiziere che gli mostra l’adulterio, ma
semplicemente come un tecnico, ancora una volta, non troppo ligio al dovere, e
magari corruttibile con una banconota, a cui non interessa la tragicità
dell’esistenza, ma solo il coinvolgimento nelle attese dei due come nella
suspence artefatta di una soap opera (come se Kim Ki-duk affidasse ai suoi personaggi, dopo averli per tanto tempo
tenuti in un silenzio terribile, tutta una serie di dialoghi troppo accorati in
cui i luoghi comuni risplendono come lame comunque strazianti, per la crudeltà
con cui ci ricordano quante volte li utilizziamo nei nostri vulnerabili, anche
mediocri rapporti amorosi - ce li fa riascoltare in registrazione, lynchianamente,
con implacabile humor nero). Eravamo avvertiti: «Siamo tutti dei folli
prigionieri nel braccio della morte». Sembra dirci, includendosi, con questa
sua presenza nel film, esattamente il contrario di quanto possiamo credere affibbiandogli il ruolo di governatore del paesaggio accidentato, di
demone creatore che manovra le esistenze dei suoi personaggi. Egli sembra dire
piuttosto: sono un occhio, uno sguardo, a volte grazie a uno stratagemma posso penetrare nelle cose, ma queste si disfano da sè: ogni
giorno scalfitture, ferite; questa volta non vi mostro le piaghe, nemmeno le
fasciature e le bende: siamo in un ospedale-prigione gigantesco, non riesco più
nemmeno ad accarezzare i volti dei superstiti, perché devo correre a filmare i
volti anestetizzati dei non-morti: il Tempo diventa la chiave che ci percuote
tutti tanto forte che non è sempre necessario mostrare le cicatrici di tali
colpi; il mutismo, che aveva una sua intensità e potenza terrificante, emotiva,
sempre più spesso non regge all’urto col reale, tanto da diventare
balbettamento insensato, materiale da soap che ci riguarda nostro malgrado: la febbre in Time e in Soom è talmente
sgradevole e veritiera che ci tocca da vicino, se a una prima occhiata
l’avevamo etichettata come delirio perfino imbarazzante. O forse, per vivere, è
necessario imperversare nell’esistenza con un accanimento insensato, con la
disperazione di un amante che viene perseguitato dalle
sue proprie ombre, e come un condannato a morte – ciò che in fondo,
ambedue le cose, noi siamo.